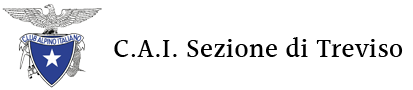Pellegrini e mendicanti di cielo
Data evento:
Ha senso oggi camminare? Ha senso camminare in montagna? Ha senso camminare prefiggendosi una meta da raggiungere, magari a costo di fatica? Camminare in vista di una meta significa essere dei pellegrini che camminano avendo sempre fissa la meta e finalizzando tutto alla meta.
L’uomo, oggi, più che un pellegrino sembra essere un viandante; va, senza nessuna meta, per il gusto di andare . È possibile essere dei semplici viandanti, percorrere il nostro cammino con la leggerezza (superficialità?), la libertà (qualunquismo?) del viandante?
Camminare bisogna; l’immobilità è morte.
Però, visto che, comunque, camminare è fatica, il problema che immediatamente ci si pone è cosa obblighi il viandante a procedere (visto che anche lo Zaratustra di Nietzsche, l’emblema stesso del viandante, vorrebbe fermarsi nell’ora in cui l’ombra è più breve). È solo questione di mostrarsi vivi? Ma a chi? E poi è vita quella che si esprime nella casualità dell’attimo? Siamo vivi o siamo travolti dallo scorrere del tutto?
Sembrerebbe che se noi assumessimo l’atteggiamento del viandante, che non ha nessun fine e quindi non finalizza nemmeno il suo camminare, il paesaggio, che nel cammino si offre e varia costantemente, venga davvero colto nella sua gratuità, nel suo valore; il pellegrino, invece, tutto proteso alla meta non sarebbe in grado di cogliere il variare continuo del paesaggio, non saprebbe osservarlo e apprezzarlo nella sua costante novità. Ma il camminare senza meta non potrebbe essere la condizione perché tutto cada nell’insignificanza? Ogni istante ha l’importanza di quello precedente e di quello successivo: tutto è importante perché tutto è equivalente e, quindi, senza senso proprio. E il trovare significato, il dare significato non potrebbe essere solo una illusione per trovare un minimo di senso in un movimento tutto determinato dalla causalità.
Il viandante ha coscienza di tutta la sua precarietà; ha coscienza che può fruire dell’attimo, dell’istante, ma la totalità è consapevole che non è a sua disposizione. Sa che la possibilità del non senso accompagna sempre quel piccolo senso che coglie nel susseguirsi degli attimi. E proprio per questa esperienza il viandante sembra essere aperto ai possibili diversi sensi; sembra disponibile ad accogliere prospettive diverse; sembra più tollerante, più aperto del pellegrino.
È vero che la totalità è sfuggente ma questo non solo per il viandante, anche per il pellegrino. Del resto il pellegrino è tale proprio perché vive dell’assenza della meta, quindi sperimenta la privazione; e proprio per questo potrebbe essere, più del viandante che coincide con l’istante e, quindi non sa differenziarsene, consapevole della propria intrascendibile limitatezza. Quindi il pellegrino sa che ogni sua visione è limitata, povera. E per questo sa che il non senso accompagna sempre quella piccola parte di senso che riesce a intravvedere. E cammina nella consapevolezza che il senso potrebbe sempre offrirsi nell’attimo successivo; di qui il suo avanzare, di qui la sua attenzione anche ai minimi dettagli che potrebbero essere portatori di nuove prospettive e possibilità. Il pellegrino sa che l’abbraccio totale è follia; ma questo non esclude che la totalità possa, in diverse maniere manifestarsi, anche se la sua manifestazione è sempre e solo un ri-velarsi (e qui potremmo imparare da Heidegger). E grazie a questa ri-velazione trova la forza per procedere (anche una volta arrivato alla meta).
Il viandante vive del viaggio e, quindi, sa apprezzare ogni istante del viaggio. E se il viaggio è la vita sa apprezzare ogni istante della vita. Il pellegrino che vive orientato alla meta non sa cogliere la positività dell’attimo presente e, in nome di una meta futura, rischia di perdere di fatto la vita. Ma niente impedisce che tutto quello che incontriamo nel viaggio sia rinvio, sia simbolo della meta; niente impedisce che gli eventi del viaggio, i paesaggi siano il parziale manifestarsi, l’accadere nel tempo e nello spazio di quella totalità che sappiamo irraggiungibile. Il pellegrino non è esentato dal presente. Il pellegrino vive il presente in tutta la sua significatività, in tutta la sua simbolicità (e qui non possiamo non ricordare i gigli del campo, gli uccelli del cielo, il grano che cresce, il banchetto….). E il presente è simbolico proprio perché è vero che la meta è assente, ma rende vivo il presente e in qualche modo rende significativo tutto il presente. La meta è già in mezzo a noi, è già presente e, per questo, niente del presente potrà mai essere insignificante per chi cammina verso il compimento della meta. È per il viandante che il presente non è simbolo di niente, quindi tutto a sua dimensione e a portata del suo potere. Per questo il vero rispetto e apprezzamento della realtà potrebbe venire proprio dal pellegrino.
È anche vero che il viandante sembra essere più rispettoso della vita, della sua non programmabilità, del suo essere ‘evento’. Mentre il pellegrino, che tutto orienta alla meta, sembra essere emblema dell’uomo occidentale e della sua pretesa ‘umanistica’ d’essere il centro e la misura del tutto; dell’uomo che vuole tutto possedere. È vero che la meta è sempre presente al pellegrino. È vero che il pellegrino sceglie la meta, ma non è lui la misura, è misurato, determinato dalla meta; è la meta che detta legge, è la meta che fa il pellegrino e non viceversa. La meta, poi, non è mai proprietà di nessun pellegrino, nemmeno quando è raggiunta. La meta è qualcosa a cui, forse, si arriva, che non è a disposizione nostra, qualcosa che resta sempre e solo meta da raggiungere e mai posseduta. Per questo la meta è sempre nuova, non è mai programmata; è sempre eccedente tutte le nostre attese. La meta è sempre e solo Terra promessa.
La meta si offre, si dona, non si conquista. Si dona; e il dono è sempre gratuità, è sempre sorpresa. E proprio perché si dona mantiene tutta la sua alterità e per questo rimane sempre e solo Terra promessa. E alla meta il pellegrino non si esaurisce; continua nel suo pellegrinaggio ed è obbligato al futuro possibile anche quando il presente è nella pienezza del significato raggiunto. E questo non per volontà sua ma proprio perché la meta è sempre altra rispetto al pellegrino. Il futuro viene dalla meta presente. Di qui la valorizzazione e tutto l’apprezzamento del presente, ma non la sua assolutizzazione. La meta diventa costante rinvio; un rinvio che non è frustrante proprio perché la meta è comunque presente. Solo che è presente non nelle nostre modalità o secondo le nostre categorie.
Il pellegrino, diversamente dal viandante fa esperienza dell’assoluto. Sceglie (o è scelto da?) la meta. La meta è il tutto, è ciò a cui tutto viene finalizzato. Non è condizionata da nulla e tutto condiziona. Quel luogo è assoluto. Un assoluto che rende significativi anche i momenti più difficili, più faticosi del cammino. Un assoluto che costantemente ti interpella senza essere immediatamente presente. Un assoluto che rende significative anche le rinunce apparentemente immotivate. Ed è un assoluto che si può raggiungere. E una volta raggiunto è lo stupore, la meraviglia, è la sua eccedenza rispetto a tutte le nostre attese. E, se la meta è una vetta, l’orizzonte esplode i tutte le dimensioni. Diventa l’infinito orizzontale ma anche l’infinito verticale, anche abissale. Un infinito che ti avvolge e che non ti schiaccia, ma libera in te dimensioni inattese, dà concretezza ai tuoi desideri, dà sintonia con tutta la realtà accolta e non dominata.
E tu cogli tutta la gratuità della tua stessa esistenza, la fragilità e la piccolezza dell’esistenza, ma, insieme, apprezzi tutta l’esistenza, sia tua sia del filo d’erba che riesce a vivere a quelle altezze… è il dipanarsi davanti a te dell’infinita ricchezza della realtà, della sua bellezza, della sua fantasia. E tu di questa bellezza sei parte non accidentale.
È un assoluto estremamente concreto, tangibile; la meta raggiunta non è una nostra illusione. Però nell’incontro con questo assoluto noi sperimentiamo, grazie alla sua bellezza, alla sua irriducibilità, qualcosa che non è solo materiale, fisico; sperimentiamo l’apertura a una dimensione di bellezza che ci rinvia oltre il dato immediato, sperimentiamo l’apertura su orizzonti altri rispetto al nostro consueto orizzonte. E la bellezza ci apre alla spiritualità della meta. E nella meta la bellezza di tutto l’orizzonte, la sua spiritualità e la bellezza e la spiritualità di tutto di tutto ciò che dall’orizzonte è custodito. E allora cogliamo come tutta la realtà, nella sua concretezza, abbia una dimensione spirituale. E da questa spiritualità forse saremo rinviati a un Qualcuno presente in questa bellezza, che si dona in questa bellezza.
È questo che ci fa apprezzare anche tutta la fatica fatta, estremamente concreta, fisica. È la meta raggiunta che ci apre a una dimensione di spiritualità che è salvezza della nostra fisicità; ed è una spiritualità resa non evanescente, non illusoria, ma sostanza, vita della fisicità. E, per questo, forse non è il viandante a salvaguardare la concretezza e la pesantezza della vita, ma il pellegrino che in ogni istante, per quanto faticoso vede la presenza e l’appello della ‘spiritualità’ della meta.
Ed è l’esperienza di questa dimensione spirituale, altra rispetto a noi, inesprimibile, indicibile, forse impensabile, che ci consente sia di comprendere la nostra povertà, la povertà del nostro pensiero, sia, contemporaneamente, di aprirci all’esperienza degli altri che di questo mistero possono aver intravisto altro rispetto a noi. Il pellegrino non ha nessuna assolutezza, né in partenza né in arrivo. Nessun fanatismo ma esperienza di una povertà che non è una condanna proprio perché visitata dalla ricchezza del mistero; di una povertà condivisa che potrebbe essere ricchezza comune.
Il pellegrino non è un idealista, non può esserlo, perché il suo cammino è fatto anche di vesciche, di piedi rotti, di ossa doloranti. Però nella bellezza e nella spiritualità della meta sa apprezzare e valorizzare proprio queste dimensioni. Non si arriva allo spirito con le fughe nel sogno, ma si arriva allo spirito con la fatica della carne. E allora potrebbe anche essere che sia proprio questo corpo affaticato la via d’accesso alla dimensione dello spirito. Per questo il pellegrino ama non solo la meta ma anche quel povero corpo che gli consente di cogliere, apprezzare e amare la meta. È la spiritualità della meta che consente di apprezzare tutta l’importanza della fisicità, del corpo. Nella meta raggiunta abbiamo la riconciliazione tra spirito e materia, tra anima e corpo…
Il pellegrino ha bisogno di soste proprio perché ama il proprio corpo; sa trattenere il desiderio che vorrebbe arrivare subito. Però, il pellegrino sa che le soste sono soste, non sono il punto d’arrivo. Sa che il desiderio va trattenuto, ma resta sempre nel desiderio, nella speranza della meta. Per questo sempre riprende il cammino vincendo la tentazione della fatica che è la tentazione di credere d’essere arrivato. Il cammino del pellegrino, allora, diventa un costante cammino di uscita anche da se stessi, dalle proprie stanchezze, dalle proprie delusioni; è un cammino retto dal desiderio e dalla speranza che non sono assolutamente gratuiti proprio perché costantemente contraddetti dalla stanchezza dalla delusione dal tempo che non passa mai.
Il pellegrino resta sempre uomo della speranza anche fosse arrivato alla meta.
Don Piero Bordignon, Professore Storia della Filosofia Pio X Treviso
RISPOSTA AL PROFESSOR DON PIERO BORDIGNON , professore di Storia della Filosofia.
Egregio professor Don Piero Bordignon
Ho letto la sua stimolazione ( direi forse meglio provocazione) sulla differenza fra Pellegrino e Viandante, e nella modestia della mia condizione di uomo normale ( sperando che Lei non dica con Jung: ‘datemi un uomo normale e io lo guarirò’ ), non ho difficoltà ad asserire che ho capito abbastanza poco del suo lungo argomentare perdendomi nelle asserzioni filosofiche ricche di citazioni specialistiche e proprio per questo a mio avviso abbastanza carenti di disponibilità alla confutazione; specialmente dato che esse sono rivolte al ‘popolo del CAI’, di cui mi onoro di far parte, che va volentieri in giro su e fra i monti, ognuno realizzando la propria passione nel modo, nelle forme e con le motivazioni che gli paiono più congeniali e che magari cambiano di volta in volta, di stagione in stagione, anche relativamente alle stagioni della vita..
Non mi resta quindi che rifarmi a quanto scritto autorevolmente da uno studioso di studi filosofici e che qui sotto riporto, sull’importanza del carattere dialogico della confutazione sperando che Lei professore voglia scendere al nostro povero livello di alpinisti per permetterci di confutare essendo il dialogo non soltanto un atteggiamento raccomandabile, ma condizione imprescindibile dell’argomentare dialetticamente.
Scrive lo studioso:
“ II carattere dialogico della confutazione
La dimostrazione dialettica, o per confutazione, che abbiamo visto essere l’unico tipo di argomentazione rigorosa praticabile dalla filosofia, si svolge necessariamente nel quadro di un dialogo, reale o fittizio, tra due interlocutori, ciascuno dei quali sostenga una tesi contraddittoria rispetto a quella dell’altro. Per questo, sin dal tempo di Platone e di Aristotele, essa è stata trattata nel quadro della dialettica, cioè della tecnica del dialogo (dialégesthai), naturalmente inteso in senso forte, cioè non come semplice conversazione, ma come discussione, come confronto fra tesi opposte, mirante a stabilire quale di esse è vera e quale è falsa. La dimostrazione vera e propria, al contrario, può benissimo essere un monologo, perché non richiede interlocutori, ma solo princìpi da cui partire.
Quando si dice che il dialogo può essere anche fittizio, si allude alla possibilità che qualcuno dialoghi con se stesso, cioè si rappresenti da solo la negazione della propria posizione e cerchi di confutarla. Questo, del resto, è ciò che fanno Parmenide nel suo poema, Aristotele nella difesa del principio di non contraddizione e Kant nella trattazione delle antinomie della ragione. Sotto questo aspetto il «dialogo», sia pure inteso in senso fittizio, sembra essere ancor più originario del «logo», cioè del pensiero, se è vero che quest’ultimo non è altro che, come Platone ha detto, un «dialogo dell’anima con se stessa» .
Il dialogo, del resto, possiede, per così dire, un carattere trascendentale, cioè intrascendibile, perché per trascenderlo, cioè per metterlo in questione, è necessario negarlo, e quindi esercitare una forma di dialogo, nel senso forte che ho indicato sopra. Esso possiede lo stesso carattere trascendentale che è proprio di tutte le posizioni autenticamente filosofiche, cioè radicalmente critiche, prive di presupposti ammessi come veri. Tale è, ad esempio, il dubbio, il quale, come ha dimostrato Descartes, è indubitabile, perché dubitarne significa riprodurlo; oppure è tale, come si diceva un tempo nella ‘scuola padovana’, la problematicità pura, la quale è improblematizzabile, perché metterla in questione significa esercitarla (5).
Un discorso analogo, oggi, si può trovare nella «pragmatica trascendentale» di Karl-Otto Apel, o nella «teoria dell’agire comunicativo» di Jürgen Habermas, nella misura in cui quest’ultimo accoglie l’«argomentazione trascendentale» di Apel, pur negando ad essa il carattere di fondazione ultima dell’etica (6). La situazione comunicativa, infatti, appare intrascendibile, cioè indiscutibile, perché per metterla in discussione è necessario, appunto, comunicare. Non mi sembra, perciò, di poter condividere le critiche mosse a questi pensatori da quanti hanno rilevato come la loro posizione presupponga una situazione di dialogo, di comunicazione, e quindi di intersoggettività, che potrebbe anche essere negata (7). Per poterla negare, infatti, sarebbe necessario riprodurla, sia pure solo idealmente.
L’accusa di presupporre una situazione di intersoggettività presuppone, a sua volta, un’interpretazione metafisico-ontologica della comunicazione, o del dialogo, come relazione tra due soggetti ontologicamente distinti, la quale non è affatto necessaria per garantire il carattere trascendentale della comunicazione, o del dialogo, cosí come non è necessaria alla trascendentalità dell’«io penso» di Kant la sua ontologizzazione in un soggetto sostanziale. Nemmeno l’affermata maggiore originarietà del linguaggio, nella sua valenza simbolica, o della disponibilità all’ascolto, rispetto alla comunicazione, riesce a dimostrare la trascendibilità di quest’ultima, perché la simbolicità, cioè la capacità di significare, e la disponibilità all’ascolto, cioè la capacità di comprendere i significati, sono appunto gli elementi della comunicazione, quando quest’ultima sia intesa non come mera situazione di fatto, ma come struttura trascendentale.
Questo discorso, a mio avviso, conserva tutta la sua validità anche indipendentemente dalla cosiddetta ‘svolta linguistica’ operata dalla filosofia analitica e dall’ermeneutica, cioè anche se si prescinde dall’assolutezza del linguaggio, da essa affermata, e si conserva al linguaggio la sua caratteristica di discorso sulle cose, totalmente proteso verso di esse e quindi posteriore ad esse (quale del resto esso era per Platone e per Aristotele). Con le sole cose, infatti, non si parla, e nemmeno si pensa, mentre per parlarne, ed anche per pensarle con quella specie di dialogo con se stessi che è il pensiero, è necessario il linguaggio, con la sua caratteristica di discorso significante per altri o almeno per se stessi. Da questo punto di vista il dialogo, per il filosofo, non è una mera situazione di fatto, o soltanto un atteggiamento eticamente raccomandabile, perché segno di disponibilità all’ascolto, al rispetto dell’altro, all’autocritica. Esso è condizione imprescindibile dell’argomentare dialetticamente, e quindi del pensare filosoficamente.”
Gentile professore, ho ricevuto l’impressione che lei faccia coincidere la figura del Viandante con quella del non credente e quella del Pellegrino col credente. Se è così, tanto più oggi , seguendo il pensiero di Papa Francesco, è necessario uscire dalle posizioni preconcette e cercare il dialogo.
Dialoghiamo quindi, ma ad armi pari: Lei professore con la sua profondità filosofica e noi con la nostra povera essenza di appassionati della montagna, ma facendo attenzione che la relazione tra chi parla e chi ascolta deve essere sempre bilaterale.
Con i più deferenti ossequi.
Renzo Secco
Categoria: Archivio news